
Sarà certamente un’opportunità in più per gli studenti di oggi, ma se si abusa di Internet a rimetterci sono proprio i voti e, in generale, l’apprendimento. Non solo. Trascorrere troppo tempo online compromette la motivazione e aumenta il livello di ansia. A suggerirlo è stato uno studio condotto dall’Università degli Studi di Milano e dalla britannica Swansea University. I risultati sono stati pubblicati sul Journal of Computer Assisted Learning. Allo studio hanno partecipato 285 studenti di corsi di laurea di ambito sanitario, valutati sotto diversi aspetti: uso delle tecnologie digitali, capacità di apprendimento, motivazione, ansia e solitudine.

Mentre ci stiamo avvicinando inesorabilmente al picco dei casi di influenza, previsto per fine mese, arriva dagli Stati Uniti un interessante annuncio: un gruppo di ricercatori della Georgia State University ha sviluppato un vaccino che offre protezione contro 6 ceppi del virus influenzale. Il preparato è stato testato con successo sui topi, ma i ricercatori confidano che i risultati possano estendersi anche agli essere umani. Si tratta di un passo importante verso la creazione del tanto agognato vaccino universale contro l'influenza. L’annuncio è stato pubblicato sulla rivista Advanced Healthcare Materials.
Il nuovo preparato usa nanoparticelle a doppio strato che contengono le principali proteine del virus dell'influenza, cioè M2 e NA. La proteina M2 è presente in tutti i virus influenzali, che ne hanno una versione simile, mentre la NA si trova sulla superficie del virus e cambia molto più lentamente di tutte le altre proteine dell’influenza. Nello studio i topi sono stati vaccinati per via intramuscolare prima di essere esposti ad uno dei 6 ceppi virali, da cui sono rimasti protetti per molto tempo. “Molti degli attuali vaccini non sfruttano la proteina Na, che sta diventando un antigene sempre più importante nella ricerca dei vaccini anti-influenzale”, commenta Gilbert Gonzalez, uno dei ricercatori.

Per decenni le donne hanno usato il talco in polvere per assorbire umidità e odori. Era diventato quasi un rito che le mamme hanno tramandato fin da piccole. Almeno fino a quando non sono emersi i primi dubbi sul possibile legame tra il talco e il rischio di sviluppare il cancro ovaie. Mentre negli Stati Uniti questo collegamento sembrava ormai assodato, ora la più grande revisione di studi sull’argomento invita a fare un passo indietro, concludendo che non c’è alcun legame evidente tra l’uso del talco in polvere sui genitali e il rischio di ammalarsi di cancro. La metanalisi è stata condotta National Institute of Environmental Health Science nella Carolina del Nord e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista JAMA.
Nel nuovo studio sono stati esaminati i dati di 4 ricerche statunitensi che hanno coinvolto un totale di 252.745 donne arruolate tra il 1976 e il 2009 e monitorate per circa 11 anni. Più di un terzo del campione (38 per cento) ha dichiarato di aver usato il talco sui genitali. Ebbene, lo studio ha rilevato che tra le donne che hanno usato il talco in polvere ci sono stati 61 casi di carcinoma ovarico per 100mila donne. Tra le donne che non avevano mai usato il talco sono stati registrati 55 casi di cancro alle ovaie per 100mila. Si tratterebbe quindi di un aumento veramente piccolo, che va dallo 0,055 per cento allo 0,061 per cento. Per questo i ricercatori hanno concluso che non esiste un’ “associazione significativa” tra il talco e il cancro.

Molti li utilizzano al posto dello zucchero per ridurre il proprio peso. Ora però scopriamo che, non solo sono inutili, ma fanno anche ingrassare. I dolcificanti artificiali a basso contenuto di calorie non hanno affatto l’effetto che tutti pensiamo. Almeno secondo i risultati di uno studio della University of South Australia pubblicato sulla rivista Current Atherosclerosis Reports. I ricercatori hanno analizzato diverse ricerche precedenti sull’argomento e da un esame complessivo è emerso che i dolcificanti provocano, a lungo termine, un aumento di peso rispetto all’utilizzo del comune zucchero.

Continua ad allungarsi la lista degli effetti benefici legati al consumo di caffè. Dopo esser stato accusato ingiustamente per anni per i suoi presunti effetti negativi sulla salute, arriva un altro studio che riabilita la caffeina. Un gruppo di ricercatori della University of Illinois ha mostrato che la caffeina agisce come un “agente anti-obesità”. Lo studio, pubblicato sul Journal of Functional Foods, è stato condotto sui topi, ma i risultati potrebbero valere anche per gli esseri umani.

Il peperoncino non è un semplice ingrediente con cui insaporire i nostri piatti. Ma, se consumato regolarmente, rappresenta uno “scudo” contro infarto e ictus, a prescindere dal tipo di dieta seguita. E, in generale, riduce il rischio di morire per tutte le cause. A rivelare il potere di questo ingrediente mediterraneo è uno studio coordinato dagli epidemiologi dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, l'Università dell'Insubria a Varese e il Cardiocentro Mediterraneo di Napoli. I risultati sono stati pubblicati sul Journal of the American College of Cardiology.
Lo studio si è basato sull’analisi delle abitudini alimentari di 22.811 molisani il cui stato di salute è stato monitorato per un tempo medio di otto anni. Dai risultati è emerso che usare il peperoncino 4 o più volte a settimana si associa a un riduzione del rischio di infarto del 40%; a una riduzione del rischio ictus di oltre il 60%; e si associa ad una riduzione del rischio generale di morte del 23%. “L’aspetto più interessante - commenta il primo autore del lavoro, Marialaura Bonaccio, epidemiologa del Neuromed - è che la protezione assicurata dal peperoncino è indipendente dal tipo di dieta adottata complessivamente, ovvero sia che si mangi in modo sano, sia che si scelga un’alimentazione meno sana, l’effetto protettivo del peperoncino è uguale per tutti”.

Sono rimasti ancora due altri importanti appuntamenti prima della fine delle feste, Capodanno ed Epifania. Fra poco più di una settimana quindi ci si ritroverà a fare i conti con la bilancia e di conseguenza con i chili accumulati a seguito delle dolci abbuffate natalizie. Niente panico: si può ritornare in forma. Purché si sia disposti a fare qualche sacrificio. “Non esistono soluzioni lampo”, precisa subito Giacinto Abele Donato Miggiano, direttore dell’Unità di Nutrizione Clinica della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma. “Per riprendersi da queste feste - aggiunge - occorrono almeno 10-15 giorni, qualche piccolo sacrificio e un po’ di attività fisica in più”.

Coloro che stanno aspettando con ansia le vacanze di Natale con la speranza di poter recuperare qualche ora di sonno perso, dovrebbero ricredersi. Perché dormire troppo potrebbe far male alla salute. Un gruppo di scienziati della Huazhong University of Science & Technology di Wuhan, in Cina, ha scoperto che chi in media dorme più di 9 ore al giorno aveva un rischio superiore del 23% di incorrere nell’ictus. Anche i pisolini durante la giornata di più di 90 minuti aumenterebbero il rischio di ictus del 25% rispetto a quelli con una durata di meno di mezz’ora. Per chi dormiva più di 9 ore al giorno e faceva anche qualche pisolino durante la giornata il rischio saliva addirittura dell’85%.

Il Natale è per eccellenza la festa preferita dai bambini. Niente scuola, regali, dolci e così via. Allo stesso tempo può essere un periodo di gran stravolgimento per i più piccoli e per questo, secondo i pediatri, è bene per i genitori organizzare vacanze natalizie “a misura di bambino”. “Durante questi giorni di vacanza, allo svago, al gioco e alla distrazione i bambini dovrebbero dedicare il proprio tempo anche ad attività che spesso tralasciano: il riposo, ad esempio, è fondamentale per i più piccoli, così come si dovrebbe evitare di esporli a dannosi stimoli sonori”, spiega la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps).

Il Natale non piace proprio a tutti. C'è chi si immalinconisce davanti a luci, addobbi e canzoni. Per evitare di diventare ancora più tristi un gruppo di ricercatori dell’Università del Kansas invita i “Grinch” a stare lontani da pandoro e panettoni o quantomeno di non abusare dei dolci. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Medical Hypotheses, gli zuccheri in eccesso porterebbero tristezza. I risultati dimostrerebbero che consumare troppi zuccheri può innescare processi metabolici, infiammatori e neurobiologici legati a malattie depressive. Se a questo si aggiunge l’effetto di una minor esposizione alla luce durante l’inverno e ai cambiamenti nei modelli di sonno, secondo i ricercatori ci si potrebbe trovare di fronte a una “tempesta perfetta” che influisce negativamente sulla salute mentale.

Non è la scusa più comune che usano le donne per rimandare l'intimità con il proprio partner. O almeno non lo è per molte. Perché è vero che l’emicrania colpisce maggiormente e più precocemente il gentil sesso. Quasi 8 pazienti con emicrania su 10, infatti, sono donne. E le donne sono anche coloro che trascurano di più la malattia. Seconda la ricerca “Vivere con l'emicrania”, realizzata dal Censis su un campione di 695 pazienti dai 18 ai 65 anni d’età, l’esordio della malattia si registra in media a 21,4 anni di età nelle donne, mentre negli uomini a 26 anni. La malattia si manifesta in maniera precoce, prima dei 18 anni, per il 42,1% delle pazienti donne, rispetto al 26% degli uomini. Eppure proprio le donne si curano di meno e dilatano i tempi della diagnosi.

La narcolessia è una malattia subdola e difficile da diagnosticare. Nel nostro paese si stima che ne soffrano dalle 12mila alle 30mila persone e che la diagnosi venga solitamente effettuata con circa 10 anni di ritardo. Per questo, su iniziativa della Associazione Nazionale Narcolettici e Ipersonni (AIN Onlus), sono state lanciate le “Red Flags”, iniziativa per promuovere la conoscenza dei segni e dei sintomi della malattia tra i pediatri e i medici. La narcolessia si manifesta attraverso una sonnolenza diurna particolare. Chi ne è affetto, nel corso della giornata fa sonnellini brevi e ristoratori, durante i quali spesso sogna, con il rischio di avere subito dopo delle allucinazioni. La narcolessia viene spesso scambiata per epilessia, psicosi, schizofrenia, depressione, disturbi del movimento o altro.

Sfoggiare una chioma perfetta potrebbe costare più di quanto si immagina. O almeno è così per le donne che ricorrono a tinte permanenti o sostanze liscianti. Un mega-studio americano, condotto dal National Institute of Environmental Health Sciences, ha osservato che questi prodotti sono legati a un significativo aumento di ammalasi di tumore al seno. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno analizzato i dati riguardanti 46.709 donne, seguite per 8 anni. Le donne facevano parte del cosiddetto “Sister study”, essendo tutte sorelle di donne che avevano avuto il tumore.
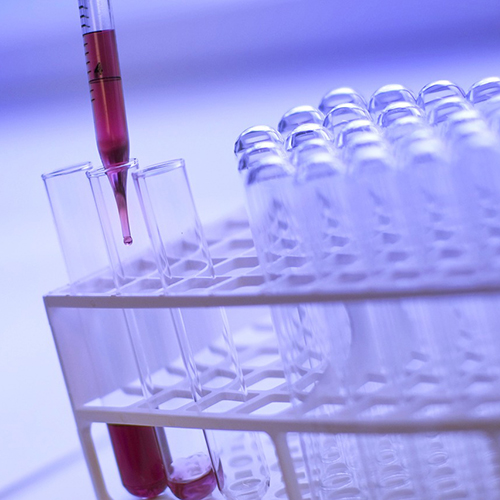
Per la prima volta in Italia un paziente è stato sottoposto a terapia genica contro l’emofilia A. E’ successo al Policlinico di Milano e questo trattamento sperimentale consentirà al paziente di evitare per diversi anni le frequenti infusioni necessarie per favorire la coagulazione del sangue, compromessa dalla malattia. Con questa terapia genica, infatti, la coagulazione del sangue di un emofiliaco diventa uguale a quella di chiunque altro, con un impatto enorme sulla sua qualità di vita. “Il primo paziente - aggiunge Flora Peyvandi, direttore Medicina Generale Emostasi e Trombosi del Policlinico di Milano e responsabile dello studio clinico - è stato trattato a inizio novembre, e oggi dopo quasi 4 settimane dall’infusione è in buone condizioni e sta conducendo la sua vita regolarmente, senza alcun particolare problema”.

Abbuffarsi a cena non è una pessima idea solo per chi vuole mantenersi in linea. O almeno non solo per questo. Uno studio della Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons di New York ha dimostrato che mangiare troppo la sera aumenta i livelli di infiammazione, che sono associati a un maggior rischio di ammalarsi di diabete e di sviluppare malattie cardiocircolatorie. Lo studio, presentato in occasione del meeting dell’American Heart Association a Philadelphia, ha riguardato solo il gentil sesso e sottolinea l’importanza di fare attenzione non solo a quello che si mangia, ma anche al quando lo si mangia.

Si lavora una vita per poter poi godere della tanta agognata pensione, ma quando poi arriva si scopre che probabilmente fa più male che bene. O almeno è così per molti, secondo quanto riferito dagli specialisti che si sono riuniti in occasione del 64esimo congresso nazionale della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) che si è tenuta a Roma. Il dato emerso nell’ambito dell’evento suggerisce che, entro i primi due anni dal momento in cui si va in pensione, aumentano gli eventi cardiovascolari, la depressione e il ricorso a medici e specialisti. In particolare l’incremento si aggira intorno tra il 2 e il 2,5%.

Non è una cura, ma una nuova efficace strategia per alleviare uno dei sintomi principali del morbo di Parkinson, cioè i tremori. Si tratta degli ultrasuoni focalizzati ad alta intensità, guidati da risonanza magnetica, che riscaldano e distruggono un piccolissimo pezzetto di tessuto cerebrale, il talamo, riducendo da subito i tremori e con una efficacia che perdura a lungo termine. A dimostrarne le potenzialità è stato un trial clinico condotto presso l’Università dell'Aquila. I risultati sono stati presentati al meeting della Radiological Society of North America a Chicago da Federico Bruno, radiologo del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze Cliniche applicate.
Lo studio ha coinvolto 39 pazienti con età media di 64 anni: 18 con diagnosi di tremore essenziale e 21 con diagnosi di Parkinson. I ricercatori hanno misurato il tremore e la qualità di vita dei pazienti prima e immediatamente dopo il trattamento, e nel corso di tutto l’anno successivo. I risultati sono stati straordinari: 37 pazienti su 39 (il 95%) hanno riportato una significativa e immediata riduzione del tremore. In pratica, la terapia con ultrasuoni è stata in grado di eliminare quella piccola parte del “talamo” che determina gli spasmi muscolari - in genere alle mani - molto invalidanti per i pazienti.

Che la natura faccia bene alla salute è ormai noto da tempo. Ci sono fior fiori di studi sugli effetti benefici degli spazi verdi: allungano la vita, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari e metaboliche, e la migliorano, riducendo lo stress e migliorando l’umore. Ma ora un nuovo studio, che ha coinvolto 7 paesi diversi, tra cui l’Italia, ha dimostrato che il verde urbano è in grado di ridurre il rischio di morire in età precoce. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista sulla rivista The Lancet Planetary Health.
Lo studio è stato condotto da un gruppo di ricercatori del Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), in collaborazione con la Colorado State University e con l’Organizzazione Mondiale della Salute (Oms), e si è concentrato sull’impatto reale del verde urbano sulla salute, confrontando la densità di verde nelle zone di residenza e il tasso di mortalità precoce per ciascuna delle zone considerate. In particolare, gli scienziati spagnoli hanno selezionato le ricerche più indicative e affidabili mai condotte sull’argomento, i cosiddetti “studi longitudinali”, che monitorano la salute dello stesso campione di individui per un lungo periodo di tempo. Ne sono state individuate 9 che hanno coinvolto un totale di 8 milioni di persone. I dati sulla mortalità prematura per tutte le cause sono stati incrociati con quelli delle immagini satellitari per calcolare l’impatto del verde sull’aspettativa di vita. Ebbene, dai risultati è emerso che un incremento del verde intorno alle case è associato in modo significativo con una ridotta mortalità precoce. In particolare lo studio fornisce una stima dell'effetto protettivo del verde: si ha una riduzione del 4% della mortalità prematura per ogni incremento del tasso di vegetazione di 0,1 (misurato con un indice specifico) entro 500 metri dalla zona di residenza.

Per la prima volta al mondo un essere umano è stato messo in “animazione sospesa”, cioè è stato sottoposto a un rallentamento delle normali funzioni vitali. Si tratta di uno stato che ricorda vagamente l’ibernazione rappresentata in molti libri e film di fantascienza. A riuscire per primi nell’impresa è stato un gruppo di scienziati dell’Università del Maryland, negli Stati Uniti. I risultati, descritti in un articolo pubblicato sulla rivista New Scientist, sono stati raggiunti nell’ambito di un trial che mira a rendere possibile la riparazione chirurgica di lesioni traumatiche che altrimenti causerebbero la morte. La tecnica, ufficialmente chiamata “emergency preservation and resuscitation”(EPR), è indicata ad esempio per tutte quelle persone che arrivano in ospedale con un trauma acuto, come un colpo di pistola o una coltellata, e che hanno subito un arresto cardiaco.

Per moltissime persone non c’è niente di meglio d’inverno che raggomitolarsi sotto uno spesso piumone. Una coccola, questa, solo apparentemente innocua. Perché se non si sta attenti al tipo di piumone utilizzato si rischia di sviluppare un'infezione polmonare che può addirittura essere letale. Martin Taylor, un uomo di 43 anni dell’Aberdeenshire, in Scozia, ne sa qualcosa. Taylor è il primo caso documentato di “polmonite da piumino”, un’infiammazione polmonare causata dall’inalazione di polvere dalle piume che imbottiscono coperte e cuscini. La sua storia è stata raccontata da un gruppo di medici dell’Aberdeen Royal Infirmary, in Scozia, in uno studio riportato dalla rivista BMJ Case Reports.
Taylor, non fumatore, ha sofferto per lungo tempo di affanno, affaticamento e malessere generale pur risultando esami del sangue e radiografia al torace. Tuttavia, continuava a essere gravemente senza fiato e il medico di famiglia gli ha raccomandato una visita specialistica. Da qui l’incontro con Owen Dempsey, autore dello studio, che nel tentativo di aiutare l’uomo ha approfondito la sua storia clinica e personale.